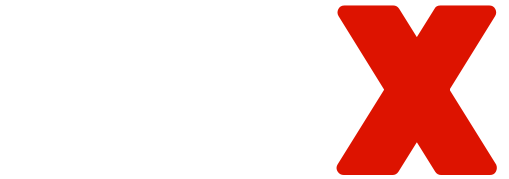In questi giorni ho rinnovato la richiesta di aspettativa dall’insegnamento: questo mi ha riportata alla scuola e alla mia scelta; sono affiorati ricordi degli ultimi giorni con le classi dell’istituto superiore dove insegnavo. Mi sono presa alcuni momenti per fare un bilancio di questi dieci mesi “fuori” dalla scuola ed è emersa la necessità di scrivere. Dieci mesi perché dopo la sospensione non sono più rientrata.
Nel settembre 2021 ho iniziato regolarmente la scuola grazie alla guarigione dalla Covid-19. Mi ricordo la sensazione di assertività e di dignità, mentre camminavo nei corridoi e incrociavo gli sguardi frettolosi di molti docenti; dignità che mi arrivava dal tenermi continuamente informata e in contatto con un’altra visione, dall’attraversare i carboni ardenti a testa alta. Sentivo al tempo stesso il solco profondo e doloroso che mi separava dai colleghi che sentivo essere ormai definitivo. Non ho mancato mai di tentare un dialogo, di portare riferimenti, articoli, ed era chiara a tutti la mia posizione, il mio desiderio di confronto e di abbracciare la complessità, come era chiaro a me che nessun dialogo sarebbe stato mai possibile. La delusione rispetto a un collettivo di docenti che a poco a poco si sgretolava – anzi neppure poi tanto lentamente –, la delusione per il mancato dibattito, la stima che portavo verso molti, tutto questo mi rendeva attonita.
Ho cercato, nei sei mesi di presenza a scuola, di portare agli studenti vitalità e ripristinare un contatto, una corporeità negata, anche con moltissime attività all’aperto. Sentivo il piacere dei ragazzi di assaporare durante le mie ore di lezione una normalità e questo mi permetteva di mantenere il focus e la motivazione.
Poi è arrivata la sospensione. Continuava il balletto dei decreti che cambiavano di mese in mese da tre anni. Così la mia esenzione cartacea alle vaccinazioni, accettata in un primo momento, veniva rifiutata il mese successivo. Senza una parola, con una fredda mail, arriva la sospensione – sì che ora la scuola appare più una azienda che il tempio della cultura e dell’evoluzione. Soltanto una lezione per salutare i ragazzi, guardarli negli occhi per dire loro che cosa stava succedendo. Salutarli. Ricordo il silenzio assoluto e lo spessore nell’aria mentre gli alunni percepivano l’importanza del momento. Ho dovuto compattarmi molto per tenere la voce ferma, c’era molto dolore, anche perché sapevo che non sarei più tornata a insegnare, quella sarebbe stata la mia ultima lezione. Ma mi sentivo al tempo stesso forte e coerente, sentivo la stima che mi perveniva dagli alunni e la loro comprensione, anche di quelli che non la pensavano come me. È stato un momento di interscambio molto significativo.
Se torno con il ricordo a quel momento e ai mesi successivi, ai passaggi che ora vado a nominare, così intensi, faccio quasi fatica a starci dentro; li sento anche lontanissimi nel tempo, sento il processo profondo che mi ha attraversato.
Ho letto con piacere l’articolo di Enrico Iavarone e Luca Panseri1 dove si parla di doppio trauma: quello dell’imposizione e quello della costante riprovazione. Ecco, ho sentito nominare esattamente il mio sentire.
Quando parlavo ai ragazzi per motivare il mio sparire nel pieno dell’anno scolastico, sentivo di testimoniare una scelta, quella di rimanere coerente con la mia visione di salute che tanto ho condiviso con gli studenti negli anni di insegnamento, coerente con quello che è il bene comune, ampio e a lungo termine.
Pensavo di restare “tranquillamente” sospesa fino a giugno, invece no, qualcosa di imprevisto, diabolico, l’ennesimo contorto decreto, sanciva la fine della sospensione per i docenti.
Sono stata contattata telefonicamente dalla segreteria della scuola perché non avevo risposto alla mail. Già, non avevo neppure letto la mail: dal momento che non percepivo stipendio, avevo ritenuto di non impiegare il mio tempo a leggere le mail della scuola. La segretaria mi diceva che dovevo recarmi con urgenza a scuola perché non esisteva più la sospensione, dovevo rientrare, ma essendo non vaccinata ero ritenuta non idonea all’insegnamento. Quindi dovevo rientrare demansionata, concordare con il Dirigente le nuove mansioni e raddoppiare le ore di lavoro. Questo è quanto succede quando si è “non idonei all’insegnamento”. Non avevo alcuna intenzione di rientrare a scuola in questo modo, vedere la mia classe assegnata a un altro docente, mentre io sana come un pesce sarei dovuta stare in segreteria a fare ciò che non mi compete.
Il decreto prevedeva – cosa che forse non molte persone sanno – che chi non accettava di firmare il demansionamento dopo cinque giorni di assenza sarebbe stato licenziato. Licenziato! Esattamente. Non potevo crederci: davvero solo una mente perversa, sadica, contorta poteva aver pensato un decreto del genere.
Licenziata in cinque giorni. Voleva dire che il concorso vinto non aveva più alcun valore, voleva dire che il sindacato non esiste più. Che l’Italia non è un paese libero e democratico. Ho preso atto di tutto questo, con alle spalle due anni di esecrazione e follia.
Stavo scivolando nel vortice del trauma. Un’esperienza più intensa rispetto a quella che potevo sostenere. Inoltre tutto stava accadendo troppo velocemente. Non era possibile un rallentamento, bisognava decidere tutto subito, con la vita che scorre, con tutto il resto che continua a richiedere attenzione e stabilità.
Non volevo assolutamente ritornare a scuola, sentivo anche che sarei arrivata alla scelta di lasciarla definitivamente, ma non volevo prendere una decisione così importante in cinque giorni.
Subito ho pensato di farmi licenziare per poter poi denunciare questo atto così violento dello Stato e del suo rappresentante, il Dirigente Scolastico, ma un avvocato al quale mi sono rivolta mi ha fortemente sconsigliato di fare ciò, perché il licenziamento sarebbe stato reale e definitivo e non sarebbe stato facile, invece, vincere la causa.
Ci sono stati momenti in cui mi sono sentita sopraffatta: percepivo sulla mia persona tutto l’abuso di potere. Mi sono sentita completamente sola, non potevo condividere o parlare con nessuno; al trauma del licenziamento si sovrapponeva la mia situazione personale di quei mesi, che non vado qui a descrivere.
In quei giorni ho preso la decisione di chiedere un’aspettativa non retribuita. Una via d’uscita possibile per i docenti che potevano farlo.
Mi sono chiesta molte volte se nella strettoia di quei giorni, con alle spalle anni difficili, potessi parlare di trauma e se, come me, ciascuno con specificità differenti stava vivendo una situazione di trauma. Nell’articolo2 del Prof. Maurizio Stupiggia vengono riferiti questi passaggi sul trauma. Henry Krystal, lo definisce così: «Il trauma psichico catastrofico è definito una resa a ciò che viene vissuto come un pericolo inevitabile di origine esterna o interna. È la realtà psichica della resa a ciò che viene vissuto come una situazione intollerabile senza via d’uscita che fa sì che si abbandonino le attività che salvaguardano la vita. La valutazione che la situazione è di estremo pericolo e la resa ad essa danno inizio al processo traumatico»3.
Quando parliamo di evento traumatico ci riferiamo a momenti in cui la persona sperimenta un terrore indicibile, in assenza di sostegno, nella difficoltà di raccontare l’accaduto e soprattutto nell’incapacità di intravedere la fine del tormento.
Ovviamente ci sono infiniti gradi di intensità del trauma: «la traumaticità di un evento può essere pienamente valutata solo tenendo conto di un insieme di variabili che comprende l’ampiezza, l’intensità e la precocità del trauma, le caratteristiche temperamentali dell’individuo, la personalità, le caratteristiche dello stile di attaccamento, gli aspetti di vulnerabilità e resilienza, ed infine le capacità di contenimento e di elaborazione della rete di relazioni affettive e sociali»4.
Ciascuno di noi in base alle risorse personali, alla sua storia, al campo di sostegno, ha risposto in modo differente, perché come ricorda Siegel: «ognuno di noi ha una finestra di tolleranza, margini entro i quali gli stati emozionali di diversa intensità possono essere processati senza che ciò comprometta il funzionamento del sistema nel suo complesso»5.
Personalmente per diversi mesi ho sentito, in molti momenti, un disorientamento: il corpo mandava segni chiari di disagio e restavo in ascolto. Ancora l’articolo citato di Enrico Iavarone e Luca Panseri parla di un mio vissuto tra resistenza e resa. Sento di aver portato nella scuola una voce in controtendenza e la testimonianza di una resistenza, di un instancabile e vitale desiderio di dare voce a una visione.
A un certo punto ho preso atto che la scuola non risuona più con me. Riconosco che mi ha dato moltissimo, ho potuto crescere e prendere sicurezza grazie anche alla scuola, seppure io non abbia mai apprezzato né compreso molte cose e abbia fatto sempre fatica ad adattarmi al suo funzionamento.
La resa ora è un prendere atto che sono stata attraversata da qualcosa di talmente grave e grande – che i miei colleghi pare neppure abbiano visto o almeno si siano dissociati completamente –, che nulla posso dare più di me in quello spazio. Sentirei di essere onnipotente pensando di poter cambiare la scuola, senza una comunità di intenti, sentirei di forzarmi troppo.
Mi sto domandando se io possa ancora portare entusiasmo nelle classi. Come sempre c’è una complessità e si creano situazioni in cui prevale la danza del paradosso. Sento che con gli alunni potrei facilmente ritrovare la spinta per insegnare e i punti di contatto con loro, dare il mio piccolo contributo – cosa non possibile, invece, con tutti gli altri componenti della comunità scolastica.
Certo, non è facile lasciare un posto di lavoro statale e indeterminato, non lasciarmi influenzare dalla credenza del lavoro sicuro, della pensione che mai percepirò, dalla paura di non farcela economicamente, e tutto il resto di cui la nostra società è impregnata.
Ma sento la resa come un affidarmi maggiormente all’evento. Come la possibilità di dedicarmi appieno alla professione di Pedagogista e Counselor che sento più confacente a me in questo momento. Quanto è successo mi porta a prendere una direzione e lasciare lo stato di part-time. Portare la mia energia, il mio tempo verso una direzione unica, quella che parla di me.
Sto imparando che in realtà ci sono alcune cose che sono già cambiate, che sono già successe e nulla torna come prima. Posso soltanto vederle e lasciare che il cambiamento mi attraversi e muova la direzione, senza resistere a un cambiamento che di fatto è già avvenuto.
In questi giorni ho conosciuto una giovane dottoressa – sospesa poco dopo essersi laureata in Medicina e delusa da alcuni aspetti della medicina occidentale – che ha deciso di orientarsi verso la Medicina Cinese. Mi sono fidata di lei, della sua passione e del suo intuito e ho fatto una seduta di agopuntura che mai avevo voluto fare in passato.
Mi ha aiutata nel processo che voglio fare sempre di più e a un livello più profondo, quello di lasciare andare e non controllare. Ha lavorato nei punti che si chiamano “Palazzo della Fatica”. Mi è piaciuto molto il nome di questi meridiani, perché è vero: si fa molta fatica a resistere, resistere all’evento, al cambiamento.
Sono rimasta a lungo sdraiata, immobile, con i palmi delle mani verso l’alto, al buio. Mi sono arrivate l’immagine del quadro di Anselm Kiefer, riportato nell’articolo Petali di Resa6 e la sensazione profonda di affidamento, qualcosa di più immenso di me nel quale mi fondevo. Ho avuto la sensazione che quella mia posizione fosse già stata, già pensata, già vista, come nel quadro di Anselm Kiefer o nel sogno di Luca Panseri7.
È in quei momenti di grazia che posso percepire che tutto è unito, tutto ha un’armoniosa concertazione, e mi pervade un senso di fiducia e possibilità. Il vuoto è un potenziale infinito e vitale. Posso solo imparare ad affidarmi a questo immenso mistero, al cielo stellato.
Patrizia Belardi
Pedagogista e Counselor Analista Funzionale
2 Stupiggia M., Il trattamento del trauma: un punto di vista neurofisiologico.
3 Krystal H., Affetto, trauma, alessitimia, Roma, 2007, p. 200.
4 Stupiggia M., Il trattamento del trauma: un punto di vista neurofisiologico, p. 3.
5 Siegel D., La mente relazionale. Neurobiologia dell’esperienza interpersonale, Milano, 2001, p. 249.